 Di solito, quando decido di andare al cinema, scelgo il film sulla base di quello di Dylan Dog chiamerebbe “quinto senso e mezzo”, una sorta di richiamo con il quale la pellicola in qualche modo mi invita ad assecondarla. Insomma, faccio di tutto per evitare locandine, sinossi e trailer. Questa volta però, sbirciando gli orari degli spettacoli, non ho potuto non incrociare due paroline che hanno finito per incuriosirmi: Spagna e guerra civile.
Di solito, quando decido di andare al cinema, scelgo il film sulla base di quello di Dylan Dog chiamerebbe “quinto senso e mezzo”, una sorta di richiamo con il quale la pellicola in qualche modo mi invita ad assecondarla. Insomma, faccio di tutto per evitare locandine, sinossi e trailer. Questa volta però, sbirciando gli orari degli spettacoli, non ho potuto non incrociare due paroline che hanno finito per incuriosirmi: Spagna e guerra civile.
Seduto in sala, prima che il film iniziasse, avevo immaginato molte varianti di ciò che da lì a pochi minuti avrei seguito sullo schermo, ma mai avrei sospettato che due dei protagonisti della storia raccontata fossero clown. E non due clown uno mimesi dell’altro – versione circense del bene e del male, almeno non al di fuori del circo – bensì due clown svitati e violenti. E la rivoluzione civile spagnola? Lo sfondo sul quale si svolgono le vicende, (forse) l’origine e conseguenza del “male” che sfocia nel disprezzo della vita e nella sete di vendetta. A ben vedere però, il centro della scena non è tanto un attore in carne ed ossa quanto un concetto astratto seppur tangibile: la tristezza. Tristezza per l’infanzia perduta, per l’affetto non ricambiato, per un destino segnato, per un amore malato, per la libertà negata. Sì, forse è proprio così, è la tristezza nelle sue diverse forme (stavo per scrivere “…e colori” ma in realtà i paesaggi del film sono quasi sempre scuri, in perfetta congruenza con lo sviluppo della trama) la vera protagonista del film, un sentimento che si lega ai personaggi segnandone il destino. Scontato quindi che, alla fine, non ci siano vincitori ma solo vinti e che le lacrime accomunino tutti coloro che nell’amore (per il proprio padre, per una donna, per il proprio lavoro, per la Patria) avevano intravisto una via di fuga.
E’ quindi forse del tutto “normale” che uscito dalla sala parte di tristezza abbia assalito anche il sottoscritto (che non si aspettava un film genere Un giorno di ordinaria follia, datato 2010 ma distribuito in Italia solo ora nonostante i due premi al Festival di Venezia), missione compiuta. Curioso.
Movie
Poetry, gli scorci poetici di Chang-dong
 I film coreani mi affascinano anche (e forse soprattutto) perché non riesco mai a capirli appieno, c’è sempre qualcosa, qualche particolare, qualche messaggio, che sfugge alla mia comprensione. Non tutto ai miei occhi appare avere un senso e questa mancanza di logicità a tutto tondo mi appaga.
I film coreani mi affascinano anche (e forse soprattutto) perché non riesco mai a capirli appieno, c’è sempre qualcosa, qualche particolare, qualche messaggio, che sfugge alla mia comprensione. Non tutto ai miei occhi appare avere un senso e questa mancanza di logicità a tutto tondo mi appaga.
Fatta questa premessa, appena ho saputo della proiezione di Poetry al tradizionale cinema all’aperto estivo, non ho saputo resistere.
Il film – opera di Lee Chang-dong premiata a Cannes – ha come protagonista Mija, un’anziana signora che, divisa tra un lavoro part time come badante e la cura del nipote, riscopre una delle sue passioni giovanili, la poesia, iscrivendosi a un corso per provetti poeti.
La vita tranquilla della signora viene però sconvolta da due avvenimenti improvvisi che ne scuotono le giornate e che riesce ad affrontare proprio grazie al proprio nuovo hobby. Anche se inizialmente non trova un metodo per riportare su carta i propri sentimenti, le proprie emozioni (forse troppo a lungo sopite), Mija alla fine risulta in grado di dar voce a quello che molti, parlando della pellicola, hanno chiamato l’invisibile (non voglio svelare troppo circa la trama e i suoi risvolti).
La particolarità del film che più ho apprezzato è stata quella relativa al completo rovesciamento delle parti tra nonna e nipote rispetto alle mie aspettative: la prima molto è più “ingenuamente pura” la cui vita è dettata da continui gesti d’amore e di apprezzamento (nei confronti degli altri, della natura, della vita in generale), il secondo invece, burbero, e menefreghista, sospeso tra la tv, il computer e i propri amici, pare capace di apprezzare solo ciò che è immediato e l’effimero.
Per la protagonista del film non si può che provare simpatia e al contempo tenerezza: una donna fragile, sola ad affrontare una vita difficile, gli acciacchi dell’età che avanza e che si trova ad accudire un nipote con il quale non riesce ad instaurare un dialogo. E che proprio grazie alla poesia riscopre la riflessione e quel “non dare mai per scontato” che le permette di accettare e superare le avversità quasi i versi siano un modo di vedere e assaporare la vita nonostante il dolore che essa spesso può procurare. Un film semplice ma che anche grazie all’ottima interpretazione di Yu Junghee e alla delicata regia di Chang-dong regala emozionanti scorci… di poesia.
The Tree of Life, un’anima persa nel mondo moderno
 The Tree of Life di Terence Mallick non è il solito film. E’ un’opera di visioni che si alternanto sullo schermo come nella mente del protagonista – l’adulto Jack (interpretato da Sean Penn) – che rivive i primi anni della sua vita con la famiglia in Texas.
The Tree of Life di Terence Mallick non è il solito film. E’ un’opera di visioni che si alternanto sullo schermo come nella mente del protagonista – l’adulto Jack (interpretato da Sean Penn) – che rivive i primi anni della sua vita con la famiglia in Texas.
Immerso nella sua vita lavorativa, circondato da grattacieli e rinchiuso in spazi artificiali, Jack affoga nei propri ricordi alla ricerca del senso della vita: la famiglia, la scuola, gli amici, i giochi, la prima cotta, il desiderio di autonomia, il conflitto con i genitori, insomma la scoperta di un mondo che via via si è dipanato davanti ai suoi occhi.
Un mondo nel quale esistono due opposti che si intrecciano: la madre che con affetto lo educa alla grazia e all’apprezzamento di tutto ciò che lo circonda e il padre che invece, severo e iperprotettivo, gli intima di non lasciarsi mai mettere sotto e di badare solo ai propri sogni e alle proprie ambizioni.
Perso nel tentativo di capire quale possa essere la strada da intraprendere, Jack viaggia con la mente (“the life journey through the innocence of chilhood to the disillusioned adult years” come recita la sinossi) ricostruendo la propria esistenza grazie a tante piccole videocartoline che si susseguono senza un ordine ben preciso alternando natura e spazio, passato e presente, realtà e immaginazione. Le onde del mare, un’eclisse, il volo di una farfalla, il vento tra le fronde degli alberi, la smorfia di un neonato, una cascata, le ombre di bambini che giocano, il riflesso della luce.
A tratti sembra una sorta di inno, un appello spirituale a vivere la propria vita amando (perchè solo nell’amore troverà compimento e non finirà in un baleno) e nella consapevolezza che il senso di tutto sarà chiaro solo alla fine del nostro “viaggio”.
La pellicola, fresca vincitrice della Palma d’oro a Cannes, è in realtà un vecchio progetto del quale da anni si vociferava l’uscita (di volta in volta associato ad interpreti diversi) che oggi, arrivato finalmente nella sale, ho diviso pubblico e critica.
Nel complesso forse eccessivamente prolisso ma di notevole impatto visivo, il film di Mallick ha saputo emozionarmi proprio in virtù della sua non linearità, del suo narrare quasi esclusivamente tramite (bellissime) immagini quasi il regista stesso – come noi in sala – non fosse altro che uno spettatore di quello che, malgrado aspetti talvolta negativi, resta il grande spettacolo della vita.
Habemus papam, fumata nera
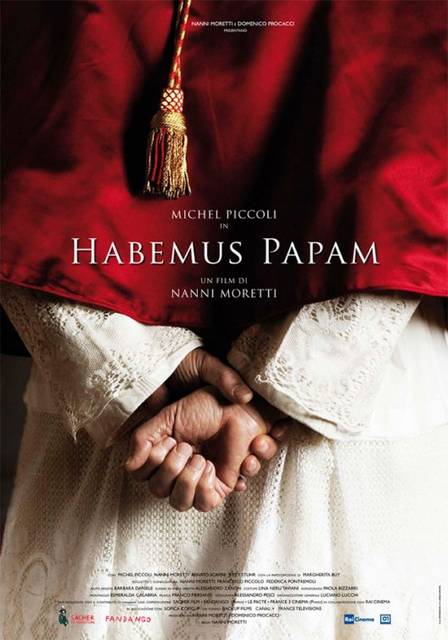 Alla vigilia della beatificazione di Giovanni Paolo II, con un tempismo quasi “divino”, mi sono recato al cinema a vedere Habemus Papam, il nuovo film di Nanni Moretti. Sarò sincero: l’ultimo lavoro del regista di Brunico non mi ha esaltato per nulla. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Moretti, presentando la pellicola, mi aveva incuriosito (anche se, con il senno di poi, la trasmissione ha probabilmente offerto un’anteprima troppo succosa proponendo quasi tutti i punti salienti del film): il solo fatto che il regista affrontasse il tema della religione mi sembrava presagire un umorismo graffiante che a conti fatti, al cinema, poi non ho colto.
Alla vigilia della beatificazione di Giovanni Paolo II, con un tempismo quasi “divino”, mi sono recato al cinema a vedere Habemus Papam, il nuovo film di Nanni Moretti. Sarò sincero: l’ultimo lavoro del regista di Brunico non mi ha esaltato per nulla. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Moretti, presentando la pellicola, mi aveva incuriosito (anche se, con il senno di poi, la trasmissione ha probabilmente offerto un’anteprima troppo succosa proponendo quasi tutti i punti salienti del film): il solo fatto che il regista affrontasse il tema della religione mi sembrava presagire un umorismo graffiante che a conti fatti, al cinema, poi non ho colto.
L’ironia capace di “pungere” mettendo a nudo vezzi e controsensi della vita, infatti, mi è sembrata essere presente solo in minima parte in Habemus Papam. E così, ad esempio, la sfida “sportiva” tra i cardinali, mi è parsa una surreale parodia più vicina a Vacanze di Natale che Palombella Rossa. Anche la sceneggiatura non mi ha colpito, a tratti irriverente e capace di strappare qualche sorriso in generale non mi ha però convinto per originalità e ritmo. Tutto viene ridicolizzato – la psicoanalisi, la fede, il conclave, le guardie svizzere… – in maniera forse eccessiva per cui alla fine del film si accettano quasi inconsciamente i timori del cardinale Melville ma non si capisce da cosa essi scaturiscano e che cosa nascondano. Il racconto insomma galleggia in superfice senza sviscerare fragilità e dubbi che assalgono il neopapa risultando in definitiva sfuggevole nei confronti del vissuto di un uomo che, inaspettatamente, si trova a dover assecondare onori e oneri del rappresentare (per chi crede, proprio per volere divino), lui fragile e mortale, Dio sulla Terra.
Sopravvalutato.
La favola del re balbuziente
 Dopo il trionfo (in parte inaspettato) agli Oscar, non ho potuto esimermi dal vedere il tanto acclamato Il discorso del re. E sinceramene non mi ha colpito particolarmente. Un film carino, a tratti simpatico, ben recitato dall’attore protagonista Colin Firth (che infatti si è aggiudicato la statuetta come migliore attore).
Dopo il trionfo (in parte inaspettato) agli Oscar, non ho potuto esimermi dal vedere il tanto acclamato Il discorso del re. E sinceramene non mi ha colpito particolarmente. Un film carino, a tratti simpatico, ben recitato dall’attore protagonista Colin Firth (che infatti si è aggiudicato la statuetta come migliore attore).
Ma non mi ha lasciato molto alla fine: la sceneggiatura, molto semplice, non è riuscita a trascinarmi e, a tratti, mi è parsa lenta e scontata. L’idea di un sovrano “imperfetto”come ognuno dei propri sudditi (e in questo molto “democratico”, alcuni osservatori suggeriscono che anche per questo motivo, sull’onda di quanto sta accadendo nel Nord Africa, forse si è voluto premiare il film per regalare al mondo un messaggio di speranza) è stata sviluppata, a mio modo di vedere, solo in maniera superficiale e per nulla corale.
Alcuni giorni dopo aver visto il film al cinema mi è tornato alla mente un altro film inglese, The Queen – La Regina datato 2006, che mi pare avere più di un’analogia con la pellicola di Tom Hopper.
Pur presentando dei monarchi praticamente agli antipodi i due film sembrano in qualche modo legati: se ne Il discorso del re la sofferenza è causata da una forma debilitante di balbuzie, in The Queen, la difficoltà di parola è dovuta alla prematura morte di un parente scomodo probabilmente mai accettato in famiglia sino in fondo. In entrambi i casi il popolo è allo stesso tempo un “test” da superare e uno “specchio” in base al quale valutare il proprio indice di gradimento. Ma mentre il logopedista Logue riesce nell’intento di far “maturare” il futuro Re Giorgio VI d’Inghilterra, il povero Tony Blair convincerà con estrema fatica la regina Elisabetta II a esprimere pubblicamente il cordoglio per la morte della Principessa Diana.
Insomma se entrambe le pellicole si focalizzano sull’istituzionalità del conservatorismo regale, paradossalmente esce dal confronto vincitore il monarca più lontano dai nostri giorni.
Concludendo: il film è piacevole ma leggerino e a mio modo di vedere complessivamente non all’altezza dei “rivali” alla corsa dell’Oscar The Social Network, Inception e Il Cigno Nero. Nonostante la vittoria finale.
Tornassi indietro mi piacerebbe vedere il film in lingua originale per apprezzare ancora di più gli attori protagonisti e le loro inflessioni.
B come Barcellona, B come Biutiful, B come Bardem
 Alejandro Gonzalez Inarritu è uno dei miei registri preferiti, il suo modo di raccontare per immagini la vita e la morte mi ha sempre affascinato (in particolare 21 grammi è il suo film che preferisco). Da pochi giorni è di nuovo nei cinema nostrani con Biutiful opera per la quale Javier Bardem ha vinto la Palma d’oro di miglior attore protagonista.
Alejandro Gonzalez Inarritu è uno dei miei registri preferiti, il suo modo di raccontare per immagini la vita e la morte mi ha sempre affascinato (in particolare 21 grammi è il suo film che preferisco). Da pochi giorni è di nuovo nei cinema nostrani con Biutiful opera per la quale Javier Bardem ha vinto la Palma d’oro di miglior attore protagonista.
Un film lungo – a tratti forse un po’ lentino – che racconta le vicende di un gruppo di individui accomunati da una vita (difficile) ai margini. In una Barcellona molto lontana dai festi di Vichy Cristina Barcellona, un gruppo di uomini e donne cerca di sopravvivere grazie a piccoli espedienti al limite della legalità. Ciò che accomuna i personaggi è un destino segnato nello stesso tempo dall’amore (tra genitore e figli, tra marito e moglie, tra amanti…) e dalla miseria di un’esistenza votata al sacrificio e amara di gioie (forse proprio per questo motivo il titolo del film è una storpiatura di termine inglese “bello”).
Mentre colonne di fumo si levano da enormi ciminiere – show must go on come cantava Freddy Mercury – la vita ai bordi della città si può semplificare in un dualismo sfruttatori-sfruttati che poco spazio lascia all’umanità.
In un consteso simile, il protagonista, Uxbal, dovrà ogni giorno dimostrarsi forte tanto da poter gestire il rapporto con i figli desiderosi di affetto e cure, con la propria fragile e volubile moglie, con “colleghi” di lavoro diversi e dalle esigenze spesso contrastanti e, infine, con il proprio corpo dalla “cagionevole salute”. Trovando non solo il modo di sbarcare il lunario ma che anche di grantire a sé stesso la pace che riesce, quando interpellato, a donare ai defunti.
Un film intenso, a volte crudo, contrassegnato dal classico “misticismo” di Inarritu che non può lasciare indifferenti.
Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni. Ma non vedrai il regista dei tuoi sogni.
 Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, ultimo film di Woody Allen, mi ha lasciato perplesso. Forse, come riflettevo alcuni giorni fa, dovrei entrare nell’ordine di idee che ripetere film come Zelig è impresa improba. Ma l’ultima pellicola di Allen non mi ha lasciato nulla: il retrogusto amaro della comicità caustica di Woody ha lasciato il posto, nell’ultimo film, a una storiella ricca di luoghi comuni, poco divertente e povera di colpi di scena.
Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, ultimo film di Woody Allen, mi ha lasciato perplesso. Forse, come riflettevo alcuni giorni fa, dovrei entrare nell’ordine di idee che ripetere film come Zelig è impresa improba. Ma l’ultima pellicola di Allen non mi ha lasciato nulla: il retrogusto amaro della comicità caustica di Woody ha lasciato il posto, nell’ultimo film, a una storiella ricca di luoghi comuni, poco divertente e povera di colpi di scena.
Nonostante il cast di primo livello – Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio Banderas, Freida Pinto – l’opera risulta un mix scombussolato di storie parallele che si sviluppano a partire dal tris d’assi amore, attrazione, relazione di coppia.
I personaggi non risultano sino in fondo credibili, di loro viene mostrata solo la parte più superficiale quasi fossero “puro istinto” e forse, anche per questo, la trama non è riuscita a coinvolgermi come invece altri lavori di Allen hanno fatto.
Il film mi ha lasciato talmente indifferente che, una volta uscito dalla sala cinematografica, ho addirittura pensato che uno dei protagonisti, lo scrittore incapace di ripetere il successo del suo esordio letterario, fosse in fondo l’ater-ego del regista. Peccato, avrei avuto proprio bisogno di iniziare l’anno gustandomi l’umorismo cinico del regista di Brooklyn.
Away we go, Sam Mandes racconta la sua American Life
 Ho iniziato il mio personalissimo “anno cinematografico” con American Life (o meglio, Away we go), il nuovo film di Sam Mandes, il regista diventato famoso per il suo esordio, il quasi omonimo American Beauty, pellicola che adoro e non mi stanco mai di rivedere (Kevin Spacey for president!).
Ho iniziato il mio personalissimo “anno cinematografico” con American Life (o meglio, Away we go), il nuovo film di Sam Mandes, il regista diventato famoso per il suo esordio, il quasi omonimo American Beauty, pellicola che adoro e non mi stanco mai di rivedere (Kevin Spacey for president!).
La storia raccontata è quella di Burt e Verona, due ragazzi sulla trentina che si trovano ad affrontare, da soli, la nascita del loro primo figlio. Raccolte le poche cose che posseggono, intraprendono un viaggio attraverso l’America – con visita anche in Canada – alla ricerca di un tetto ma anche del modello di nucleo famigliare al quale fare riferimento. Nonostante le aspettative però, il percorso si trasforma quasi subito in una serie di disavventure che sconfortano i ragazzi e che minano le loro (poche) certezze: ogni nuovo incontro per Burt e Verona anzichè rassicurarli sembra rendere di volta in volta più irreale la loro idealizzata versione di famiglia e di rapporto genitori figli. Appena arrivati ed è già tempo di ripartire senza mai perdere però la fiducia nel legame straordinario che lega i due protagonisti.
Un film delicato, capace con la sua semplicità di commuovere (un po’ alla Juno tanto per fare un paragone), la storia di due ragazzi che, armati di sogni e buone intenzioni, viaggiano alla ricerca di prove concrete circa il loro progetto di famiglia. Il momento più tenero è, a mio modo di vedere, quando i due, nel giardino del fratello di lui, su uno di quei tappeti elastici che i bambini utilizzano per divertirsi saltando, recitano una serie di promesse, una sorta di “matrimio” ateo, una cerimonia intima che sancisce una volta di più il loro essere coppia. Regia, musiche e fotografia buone, sceneggiatura mai banale, American life è uno di quei film senza alcuna particolare pretesa che riesce a strappare un sorriso e una lacrima insieme. Consigliato per ritrovare il buon umore.
Il fenomeno Facebook, dal libro alle sale
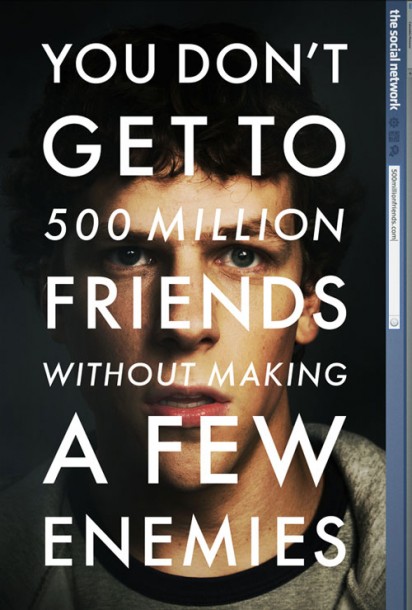 Appena saputo dell’uscita anche in Italia del film The Social Network sono corso in libreria ad acquistare il testo di Ben Mezrich alla base della pellicola. Si tratta di Miliardari per caso opera che tenta di ricostruire la genesi di Facebook, dalla stanzetta di uno studentato ad Harvard al successo planetario di una piattaforma – quella ideata da Mark Zuckerberg – che ha cambiato il concetto stesso di Internet. Il libro è una lettura appassionante (finito in poco più di una settimana), una via di mezzo tra una biografia non autorizzata, un romanzo di appendice e un favola che racconta la consacrazione di Mark a un nuovo eroe “digitale”. Una storia che in poche pagine affronta – con un ritmo incalzante – temi quali amicizia, ambizione, genio, sregolatezza, invidia, tradimento e successo, sintetizzando perfettamente molti dei “lati” che contraddistinguono i nostri comportamenti sociali e quindi, in ultimo analisi, noi stessi.
Appena saputo dell’uscita anche in Italia del film The Social Network sono corso in libreria ad acquistare il testo di Ben Mezrich alla base della pellicola. Si tratta di Miliardari per caso opera che tenta di ricostruire la genesi di Facebook, dalla stanzetta di uno studentato ad Harvard al successo planetario di una piattaforma – quella ideata da Mark Zuckerberg – che ha cambiato il concetto stesso di Internet. Il libro è una lettura appassionante (finito in poco più di una settimana), una via di mezzo tra una biografia non autorizzata, un romanzo di appendice e un favola che racconta la consacrazione di Mark a un nuovo eroe “digitale”. Una storia che in poche pagine affronta – con un ritmo incalzante – temi quali amicizia, ambizione, genio, sregolatezza, invidia, tradimento e successo, sintetizzando perfettamente molti dei “lati” che contraddistinguono i nostri comportamenti sociali e quindi, in ultimo analisi, noi stessi.
Per capire da dove nasca la rivoluzione forse occorre però fare un passo indietro e spendere due parole sull’organizzazione della vita dei college: al mattino gli studenti seguono le lezioni (il percorso di studi può variare moltissimo da studente a studente, difficile conoscere tutti i compagni dei diversi corsi) e, una volta terminate le lezioni, possono tornare nei loro alloggi, vedersi con gli amici o partecipare agli eventi che offrono i vari “circoli” dei quali fanno parte, gruppi di studenti i più famosi dei quali molto esclusivi (i membri vengono selezionati con “cura” e devono poi superare varie prove per essere ammessi in maniera definitiva) che garantiscono agli “associati” feste, ragazze, fama e aiuto in caso di bisogno. Ma perché non dare a tutti la possibilità di conoscere con immediatezza le persone con le quali si entra in contatto, condividendo con loro i propri gusti, piuttosto che il proprio stato sentimentale, semplificando così di molto la costruzione di una rete sociale e sintetizzandola in un click? Fine dell’oligarchia.
Il libro racconta tutto questo attraverso l’epopea di Zuckerberg che, da nerd in felpa a cappuccio e infradito si trasforma nel CEO di una delle più grosse società del web diventando, nel giro di pochissimi anni, il più giovane miliardario del pianeta.
La versione cinematografica prende spunto dal libro ma in parte trasforma le vicende adattandole al linguaggio tipico dei film: rispetto al testo si punta quasi esclusivamente sulla figura di Mark (Mark vs resto del mondo potrebbe essere il sottotitolo della pellicola) e sul suo egoismo che lo identifica come un ragazzo scaltro quanto “stronzo”. E solo, quasi incapace di mantenere dei rapporti con le altre persone (pare sentirsi a proprio agio solo di fronte allo schermo di un computer). Un ragazzo al quale forse viene chiesto di crescere troppo in fretta ma verso il quale però non si può non provare – almeno guardando il film – simpatia e tenerezza.
Libro e film mi sono entrambi piaciuti ma se dovessi fare il gioco della Torre, sceglierei il testo rispetto alla pellicola, più verosimile (e forse per questo meno “leggero”) e maggiormente in grado di dare un’idea di come siano andate le cose (anche se, non esseondo un ricostruzione ufficiale, molti punti restano al meno in parte oscuri). Attori comunque bravi a calarsi nei diversi ruoli, regia – quella di David Fincher – e sceneggiatura – di Aaron Sorkin – che sono una garanzia e musiche di Trent Raznor che fanno da sfondo a una pellicola che ripercorre, con simpatia (strizzando l’occhio al mondo teen), i retroscena della nascita di Facebook, ormai sdoganato a “fenomeno di massa”.
Il segreto dei suoi occhi: mille passati, nessun futuro
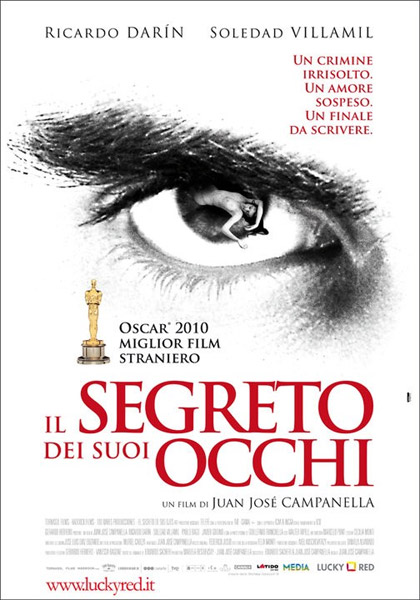 Il segreto dei suoi occhi è il film che, a sorpresa, è riuscito ad aggiudicarsi la statuetta di miglior pellicola straniera agli Oscar 2010. Girata tra Argentina e Spagna l’opera segna il ritorno nei cinema di Juan José Campanella che, prendendo spunto dall’omonimo libro di Eduardo Sacheri, racconta le vite di un gruppo di persone tra loro accumunate dall’essere entrati in contatto – chi direttamente, chi indirettamente – con il brutale omicidio di una giovane donna.
Il segreto dei suoi occhi è il film che, a sorpresa, è riuscito ad aggiudicarsi la statuetta di miglior pellicola straniera agli Oscar 2010. Girata tra Argentina e Spagna l’opera segna il ritorno nei cinema di Juan José Campanella che, prendendo spunto dall’omonimo libro di Eduardo Sacheri, racconta le vite di un gruppo di persone tra loro accumunate dall’essere entrati in contatto – chi direttamente, chi indirettamente – con il brutale omicidio di una giovane donna.
A ben vedere però i veri protagonisti del film sono da un lato le passioni, dall’altro gli occhi. Le prime governano il nostro agire, sono pulsioni che ci trascinano e che non possiamo costringere in un angolo, fonte di entusiasmo, di bramosia, di dolore e quindi, in sintesi, sinonimo di vita.
I secondi, invece, non rappresentano solo lo “strumento” con il quale noi guardiamo il mondo ma sono lo specchio di come il mondo ci vede, “parlano” di noi ai nostri interlocutori che tramite i nostri occhi riescono a farsi un’idea della nostra indole e del nostro stato d’animo.
Il film diventa allora una sorta di “parata” di sguardi: rabbia, delusione, malinconia, rassegnazione, paura, desiderio, sofferenza, curiosità, stupore sino agli occhi spenti della morte, la pellicola mostra le diverse facce dei personaggi in un intrico di occhi che rapprensentano un arcobaleno di stati d’animo differenti.
Il segreto dei suoi occhi – a metà strada tra drammatico e thriller – è un film forse dal ritmo a tratti un po’ lento ma comunque di piacevole visione, con attori bravi a interpretare i ruoli loro assegnati, una regia essenziale e un filo narrativo via via sempre meno cupo.
