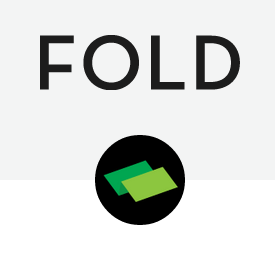Img: adage.com
Quando alcuni giorni fa si è diffusa la notizia circa l’annuncio da parte di Verizon – colosso statunitense della telefonia – di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto di AOL (4,4 miliardi di dollari, 50 dollari ad azione), molti hanno sottolineato come l’operazione sancisse il successo dei “contenuti”. In effetti AOL, nel corso degli anni, ha saputo trasformarsi da provider e gestore di servizi (chi non ricorda C’e posta per te?) in una delle più rilevanti realtà statunitensi del comparto digital media con, nella propria faretra, frecce quali The Huffington Post, TechCrunch e Engadget.
L’impressione però è quella che Verizon non si appresti ad acquistare AOL per le redazioni – seppur di primo piano – quanto per ciò che tiene uniti i diversi spazi informativi, l’Ad Network. Seguendo una strategia differente da quella del “rivale storico” Yahoo – che ha puntato su tecnologie di contenuti quali Yahoo Answers e Tumblr – AOL ha focalizzato i propri sforzi economici nello sviluppo di una piattaforma pubblicitaria in grado di sfruttare, oltre agli spazi di proprietà, anche un network di altri siti (più di 450 publisher) attraverso i quali diffondere i messaggi pubblicitari dei propri inserzionisti.
Inoltre, con l’acquisto nell’estate 2013 di Adap.tv, AOL ha voluto nuovamente imprimere un cambio di velocità all’azienda. Facendo tesoro della propria esperienza nel campo del display advertising, infatti, AOL ha deciso di scommettere sul formato video, evoluzione interattiva e multimediale del banner.
In realtà AOL ha dimostrato un certo interesse per i video non solo sotto il profilo meramente pubblicitario quanto anche dei contenuti di intrattenimento: AOL Originals e Huffington Post Live rappresentano due degli esperimenti con il maggior seguito. Con il primo AOL si cimenta nella vera e propria produzione di contenuti video premium, con il secondo fa concorrenza online ai canali all news televisivi.
In fondo, è lo stesso Tim Armstrong, CEO di AOL che, informando i dipendenti della trattativa con Verizon, ha presentato l’azienda come una “media platform company” che, vinta la sfida del video, punta ora al successo nel mobile. Con percentuali sempre più in crescita di traffico in mobilità (Armstrong indica in 80% la percentuale della media consumption prevista per i prossimi anni), poter contare su un’infrastruttura come quella di Verizon potrebbe consentire a AOL di, diciamo così, chiudere il cerchio imponendosi sul mercato pubblicitario come punto di riferimento.
Non stupisce dunque che, proprio mentre nel quartier generale di New York si brindava alla vendita di AOL, tra i giornalisti dell’azienda iniziasse a serpeggiare qualche timore. Prima di tutto per l’indipendenza verso un colosso che su temi quali la net neutrality e la privacy online non si è dimostrato apertissimo al confronto. E, in secondo luogo, vista la difficoltà di rendere l’industria del giornalismo online scalabile e profittevole, la paura riguarda potenziali cambi nella strategia del neonato gruppo che potrebbero portare a un ridimensionamento proprio dei contenuti. Malgrado questi siano necessari ai video pubblicitari.